(segue da qui)
II
IL PRINCIPIO DI CONTRADDIZIONE
A quelli dei miei lettori che non sono al corrente di queste questioni, io posso offrire un esempio che equivale ad una definizione del principio fondamentale della critica interna estremista.
Si tratta di due frasi di Guerra e Pace di Tolstoj, segnalate da Paul Souday in uno dei suoi articoli, [1] entrambe relative alla battaglia della Moscova (che Tolstoj chiama la battaglia di Borodino).
Ecco la prima di queste due frasi:
«Se è consentito giudicare gli ordini di Napoleone sbarazzandosi dell'influenza quasi superstiziosa che esercitava il suo genio, è evidente che il suo piano mancava di trasparenza e di chiarezza. Questo documento (l'ordine di marcia) conteneva quattro disposizioni di cui nessuna poteva essere e né fu eseguita» (Guerra e Pace, 3° parte, capitolo 9).
E, tre pagine più oltre, ecco la seconda, sempre a proposito della battaglia di Borodino:
«Le sue disposizioni erano meglio prese di quelle che gli avevano fatto procurare altre vittorie... Napoleone a Borodino aveva svolto il suo ruolo di rappresentante del potere altrettanto bene e anche meglio che nelle sue altre battaglie. Egli si era attenuto alle misure più sagge...», ecc. (capitolo 10).
Siamo in presenza di un caso tipico. Per la critica interna estremista, l'esitazione non è permessa. Vi è una contraddizione assoluta tra i due testi: nell'uno, le disposizioni prese da Napoleone erano buone; nell'altro, esse erano cattive. Ora, nessuno può affermare allo stesso tempo una cosa e il suo contrario. Quindi Tolstoj non ha potuto scrivere entrambe le frasi. L'esistenza di due scrittori è evidente; il nome di Tolstoj nasconde due scrittori i cui testi sono stati combinati. Il criterio gioca a pieno regime.
La critica interna è fondata, se ci si permette l'espressione, sull'impiego a fondo del principio di contraddizione.
Ma prima vanno dati alcuni esempi del modo in cui i critici estremisti applicano il loro metodo, non per sommergerli di ridicolo, ma per mostrare che non stiamo esagerando per nulla.
Nel momento in cui la sociologia francese raccoglie e classifica i documenti di ogni sorta che, attraverso l'universo, sono suscettibili di chiarirci sulla mentalità religiosa, nel momento in cui la scienza tedesca ritrova nei testi iraniani (a prezzo di quale fatica!) le antiche dottrine in mezzo alle quali è nato il cristianesimo, si vedrà a quale gioco derisorio si diverte, nel corso di quattro e anche cinque volumi, l'eroe della critica interna!
Notiamo alcune delle leggi poste da costui.
1° Un superiore non si è mai ricreduto.
C'è un incestuoso nella comunità di Corinto. Ora, 1 Corinzi 3:5, San Paolo ordina che sia consegnato a Satana; e, 1 Corinzi 5:7, ordina che sia cacciato dalla comunità.
Lo stesso uomo non può aver dato due ordini dissimili: non è quindi lo stesso autore che ha scritto i due passi. [2]
2° Uno scrittore non può a turno lodare e biasimare le stesse persone.
In molti passi, specialmente nella seconda epistola ai Corinzi, San Paolo attacca i Dodici; in altri passi, li tratta con considerazione.
Questi passi provengono quindi da scrittori diversi.
3° Altra legge della critica interna estremista: Uno scrittore non può deviare dalla verità né coscientemente né inconsciamente.
San Paolo racconta, nell'epistola ai Galati, che egli è stato riconosciuto apostolo dei pagani dai capi degli apostoli. Ora, la cosa è falsa, secondo il libro degli Atti.
Non sosteniamo che San Paolo abbia potuto avere delle ragioni per disporre le cose a seconda delle sue pretese o che scrisse dodici anni dopo l'evento. L'abate Turmel non ammette alcuna scusa; il testo dell'epistola ai Galati non è suo. [3]
4° Uno scrittore non può ripetersi.
Le cose che San Paolo scrive ai Corinzi, è inammissibile che non le abbia già dette loro; ora, in questo caso, avrebbe dovuto scrivere: «Non vi ricordate che vi ho detto che...».
Il testo non contiene nulla del genere: non è quindi suo. [4]
5° Uno scrittore non scrive nulla che non debba essere preso alla lettera.
Nell'epistola ai Romani, capitolo 9, San Paolo professa che appartengono alla posterità di Abramo solo gli ebrei che hanno la fede nel Cristo. Nel capitolo 11, non si parla più di quella restrizione e tutto il popolo ebraico è un popolo santo per la santità dei suoi padri.
«L'opposizione», dice nei suoi termini l'abate Turmel, «è assoluta, irriducibile!» [5]
Ovviamente, uno stesso oratore non potrebbe dire una volta: «Voi soli siete veri francesi, che avete fatto questo o quello», e un'altra volta: «Voi che siete francesi, essendo figli e nipoti di francesi»... L'opposizione sarebbe assoluta, irriducibile.
Altro esempio.
L'autore dei passi 2:11-13 e 3:1, dell'epistola ai Colossesi avrebbe professato [6] che la resurrezione si fosse interamente compiuta per i cristiani in quella del Cristo, e di conseguenza che non vi fosse altra da attendere per loro. Non scrive, in effetti, in Colossesi 3:1: «Voi siete resuscitati con il Cristo». Parole evidentemente decisive.
Così, la persona che direbbe che dopo la battaglia della Marna la Germania aveva perso la guerra intenderebbe necessariamente e obbligatoriamente che la guerra fosse cessata, alla fine del settembre 1914, con la disfatta della Germania.
Parleremo più oltre delle contraddizioni rilevate a proposito dei cibi permessi o proibiti e a proposito del matrimonio. Potremmo citare un gran numero, un grandissimo numero di casi analoghi. L'abate Turmel non si accontenta di esigere dallo scrittore che non si contraddica, non si smentisca e non si ricreda mai; vuole che egli intraveda, quando scrive, tutte le conseguenze che potrebbero trarne, non solo i suoi contemporanei, ma i secoli a venire; basta che lui, l'abate Turmel, possa scoprire tra le conseguenze che trae da due testi, una contraddizione che fino a quel momento, e per milleottocento anni, era passata inosservata, perché proclami: lo stesso San Paolo non ha potuto scrivere questi due testi.
Sento che darò all'abate Turmel una reputazione di umorista, come in passato Alphonse Allais, il quale otteneva i suoi migliori effetti comici traendo semplicemente dalle cose le loro estreme conseguenze... Il caso sarà più serio quando vedremo, in un prossimo capitolo, il critico deviare dalle regole del gioco e praticare il colpo di spugna...
Questo a significare che nelle epistole, intendiamo tra le parti di esse che consideriamo autentiche, non esistano contraddizioni?
Tutt'al contrario. Se un gran numero di quelle che vediamo segnalate dalla critica interna appartengono al dominio della fantasia, ne esistono un gran numero che sono reali.
Si potrebbe obiettare, in generale, che quelle non sono necessariamente, come è il caso in Guerra e Pace, il lavoro di uno scrittore che si smentisce lui stesso a tre pagine di distanza. Bisogna ricordarsi, infatti, che il testo attuale delle epistole è stato costituito accostando lettere diverse messe pezzo per pezzo e talvolta interpolate l'una nell'altra; così si riconosce generalmente nelle due epistole ai Corinzi l'assemblaggio di cinque o sei lettere indipendenti. Il fatto è ammesso anche dai critici quasi-conservatori. [7]
Ma la spiegazione non può valere per tutti i casi e, senza soffermarci oltre, poniamo in linea di principio che esistono, in effetti, nelle epistole, numerose contraddizioni.
E, prima di tutto, quelle che sfuggono così spesso all'attenzione della maggior parte degli uomini. Non c'è ragione, infatti, di negare agli scrittori sacri, più che ad altri mortali, il diritto di essere a volte incoerenti, di non sempre concatenare le loro proposizioni con un perfetto rigore, nonché di ricredersi e persino di ripetersi, infine di prendersi all'occasione qualche libertà con la verità storica, vale a dire di commettere i mille piccoli difetti che, ahimè, commettiamo noi stessi, senza vederci perciò contestata la nostra identità.
I nostri critici non hanno mai ricevuto una lettera, letto un articolo, ascoltato un discorso in cui la connessione delle idee lasciasse a desiderare? Non siamo, in ogni caso, più esigenti di quanto lo sia nostra madre Chiesa che, pur venerando nei libri del Nuovo Testamento la collaborazione dello Spirito Santo, non li propone ai suoi seminaristi come modelli di composizione.
Ma c'è di più.
Tra le varie parti delle epistole che consideriamo l'opera di San Paolo, siamo i primi a riconoscere che esistono talvolta delle differenze dottrinali che vanno al di là delle piccole contraddizioni in cui ciascuno può cadere; ed è questo che va dichiarato apertamente. Le persone che non hanno letto i libri dell'abate Turmel concluderanno che gli esempi che ho scelto da essi non sono che le esagerazioni alle quali, volendo troppo provare, si sarebbe lasciato andare un uomo che, nella sostanza, avrebbe ragione e si domanderanno se non basterebbe salvare il salvabile ? ...
È certo che il caso sarebbe giudicato se si trovassero fianco a fianco nelle epistole le dottrine che costituiscono ciò che chiamiamo il paolinismo e le dottrine diametralmente opposte: per esempio, l'affermazione che Gesù fosse un uomo tra gli uomini scelto da Dio per compiere l'opera messianica, e non un essere divino esistente in cielo da tutta l'eternità e disceso sulla terra per consegnarsi alla crocifissione; per esempio, ancora, che la legge mosaica debba essere mantenuta e osservata in tutta la sua integrità; per esempio, ancora, il riconoscimento della supremazia degli apostoli galilei e la sottomissione perfetta alla loro autorità. Ma c'è appena bisogno di dire che non si trova alcuna traccia di questo anti-paolinismo.
Per contro, non si può negare che esistono divergenze reali nelle istruzioni che danno le epistole su un certo numero di questioni, le quali, a dire il vero, non toccano l'essenza della dottrina, ma hanno nondimeno la loro importanza. Come queste:
I discepoli di San Paolo possono mangiare le carni macellate che sono state consacrate a falsi dèi?
Il matrimonio è da raccomandare? I vedovi e le vedove, in particolare, possono sposarsi una seconda volta?
L'osservanza delle leggi mosaiche è proibita o semplicemente inutile? E, in generale, quale posizione si dovrebbe prendere nei confronti del giudaismo?
Infine, la seria questione della resurrezione. San Paolo concepisce la resurrezione alla maniera ebraica o alla maniera ellenistica?
Su tutti questi punti, si trovano, nelle epistole, soluzioni divergenti. Invece di dichiarare pesantemente e senza sfumature: «San Paolo ha ordinato questo, non ha potuto ordinare ciò»... «Se San Paolo ha insegnato questo, non ha potuto insegnare ciò»... non si potrebbe, con un miglior senso della realtà, riconoscere in queste divergenze la traccia di due scuole, di cui l'una avrebbe insegnato, per esempio, che la legge mosaica era condannata e l'altra che era inutile; due scuole, di cui l'una avrebbe professato la tolleranza e l'altra il rigorismo; di cui l'una avrebbe inteso la resurrezione alla maniera dei Farisei e l'altra in una maniera ellenistica, e i cui scritti sarebbero stati riuniti sotto il nome di San Paolo, seguendo una politica di conciliazione che sarebbe stata quella della Chiesa Cattolica? ... La tesi, almeno a priori, è difendibile; l'abate Turmel l'ha intravista solo incidentalmente; più astuti di lui tra i critici estremisti, come i signori Whittaker e Rylands, l'hanno sostenuta; essa è, in ogni caso, l'unica che possa perorare la critica interna, e, sfortunatamente per quest'ultima, essa è nondimeno una cattiva tesi.
Di fatto, mai queste divergenze hanno il carattere di contraddizioni positive che vorrebbero dare loro i critici estremisti. Da nessuna parte, nelle epistole, la tolleranza è perfettamente tollerante, né il rigorismo assoluto; sulla legge mosaica stessa, le affermazioni più positive restano suscettibili di sfumature, e mai vi si legge la condanna categorica che più tardi pronunceranno i Padri. Quanto alla resurrezione farisaica (quella da cui si è fatto il giudizio finale), essa vi è sempre più o meno cristianizzata, e quanto alla resurrezione ellenistica (l'anima che sale al cielo subito dopo la morte senza aspettare il grande giorno), vedremo nel prossimo volume che la cosa non è così categorica. Ma l'importanza di queste divergenze è, in fondo, secondaria; la questione è di sapere se queste corrispondono alle dottrine di scuole rivali, oppure se esse esprimono le tendenze diverse e talvolta opposte che possono coesistere, non solo in un gruppo, ma in un uomo.
Nessuno nega, tra gli studiosi indipendenti, che il cristianesimo primitivo sia stato un fermento di contraddizioni, e anche di contraddizioni che sembravano dover rimanere in antagonismo assoluto, come le sue tendenze giudaizzanti e le sue tendenze ellenistiche; ma si vorrebbe che queste tendenze si siano distribuite regolarmente tra gruppi strettamente determinati, senza mai riversarsi dall'una all'altra, come se si fossero costituite attorno a precisi catechismi. Non si può negare che certi principi, certe regole abbiano dominato in ciascuno di questi gruppi; ma non si può concepire la chiesa primitiva come un parlamento dove è impossibile per i socialisti della S. F. I. O. concedere qualcosa all'Union Républicaine des Gauches, e dove un radicale socialista è sconfessato se fa una concessione al programma dei vicini. Basta leggere i primi capitoli della prima epistola ai Corinzi per vedere che non era così a Corinto, e l'epistola ai Galati mostra che non andò meglio altrove.
Tutto ciò significa che il fermento di tendenze opposte che agitava il cristianesimo primitivo, agitava ciascuno dei suoi gruppi e, in realtà, agitava i più vivaci almeno dei membri di questi gruppi. E noi siamo qui al cuore stesso del problema.
Il postulato inconfessato della critica interna estremista è la negazione dell'homo duplex. Non ci sono nell'uomo tendenze contraddittorie, o se ce ne sono, accade che una di esse sopprima le altre. Per il critico interno estremista, l'inquietudine è una parola vuota di senso; non ci sono uomini divisi con sé stessi; non ci sono uomini lacerati; ogni uomo è una magnifica unità in cui tutto è equilibrio. Infatti, per la critica interna, l'uomo è sempre tutto d'un pezzo; in quanto realtà psicologiche, conosce solo quei personaggi dei drammi romantici, un Ruy Blas, un Hernani, la cui linea non varia mai.
Una volta posto il carattere di San Paolo, tutto ciò che si discosta dal tipo deve essere scartato. Certo, si consente che vi sia una evoluzione; prima della sua conversione era questo; dopo, è stato ciò; ha potuto ancora evolvere in seguito. Ma in ciascuno di questi periodi, e per la durata di ciascuno, egli ridiventa l'uomo tutto d'un pezzo. Come Jean Valjean, galeotto prima dei candelabri del vescovo di Digne; eroe, dopo; questo, con un periodo intermedio altrettanto debitamente caratterizzato. Ecco un libro (parlo dei Misérables) in cui l'abate Turmel avrà difficoltà a trovare tipi che si contraddicano. Ma forse Jean Valjean non è un esempio ben reale di umanità.
Le idee moderne vanno in una tutt'altra direzione. Come queste pagine dove il signor André Maurois spiegava [8] la complessità degli esseri umani e, ricordando gli studi del signor Ramon Fernandez sullo stesso argomento, riassumeva così i temi dostoevskiani e proustiani:
«L'uomo diventa simile a quelle colonie di animali marini che vivono in fondo al mare. È una colonia di sentimenti, un polipo di personalità».
Ecco che si accorda male con il postulato della critica interna.
In Deux hommes en moi, il signor Daniel-Rops prende per epigrafe il verso celebre di Racine
Mio Dio, quale guerra crudele!
Io trovo due uomini in me...
Due uomini, in effetti, due scrittori diversi le cui opere sono state unite, spiegherebbe la critica interna estremista...
Io ho annotato alcune righe che il signor Edmond Jaloux ha scritto a proposito di uno dei miei libri di giovinezza.
«Ci è più facile giudicare un amico di tre mesi che un amico di vent'anni, perché l'amico di tre mesi ci ha fornito l'osservazione di un certo numero di tratti, nei quali possiamo formulare il suo carattere; ma l'amico di vent'anni ce ne ha forniti così tanti e così contraddittori, che ci rifiutiamo di portare su di lui il minimo giudizio, benché ne sappiamo infinitamente di più su di lui che sul primo». [9]
Io cito di preferenza gli scrittori sono specialisti di cose accademiche. Come sarebbe se si facesse appello a studi analitici recenti? Leggevo ancora da qualche parte che siamo manovrati da una miriade di motivi inconsci e irrazionali, e che la parte cosciente e razionale della nostra attività è una infima porzione della nostra personalità.
Queste forze inconsce, questi istinti, queste tendenze, l'educazione le padroneggia? A volte li attenua, quando la vita asservisce un uomo; a volte li esaspera.
È impossibile fare qualsiasi lettura senza imbattersi in osservazioni che non si può fare a meno di applicare immediatamente al problema che ci occupa. Come ad esempio, su J. J. Rousseau, queste righe del signor A. Schinz. [10]
«Tutti coloro che hanno tentato di sistematizzare il pensiero di Rousseau hanno dovuto riconoscervi, quando erano sinceri, delle singolari contraddizioni! La persona stessa di Rousseau è, infatti, complessa; essa è duplice, ed è restata duplice anche nelle opere della sua maturità. Non è arrivato (l'ha voluto?) a fare in sé l'unità».
Questi due Rousseau sono quelli che il signor Schinz chiama il «Rousseau romantico» e il «Rousseau romano». Si dovrà distinguere un Rousseau romano al quale, cinquant'anni più tardi, sarebbe stato aggiunto un Rousseau romantico?
Come, su André Gide, queste righe del signor Philoxène Bisson: [11]
«Tutte le contraddizioni alle quali non solo egli non cessa di dare ascolto ed espressione, ma che sono ben realmente infuse nella sua natura».
Apprenderemo che il nome di André Gide è la firma di una società in nome collettivo costituita da un certo numero di redattori della Nouvelle Revue Française?
Escludere dall'uomo questi conflitti di tendenze è, infatti, ancora più impossibile se si immagina che una grande personalità è, tra tutte, il luogo dove si affrontano le visioni contraddittorie, e che le grandi personalità sono spesso le più ricche di pensieri antinomici. Ed è spesso proprio da questo conflitto che risulta la loro grandezza.
Non amo impiegare il termine «primario» nel senso peggiorativo in cui è comunemente usato, avendo sempre trovato nei rappresentanti dell'insegnamento primario che ho conosciuto una curiosità intelligente che non sempre ho trovato altrove. Essendo però la parola comoda, dirò che niente è più «primario» che rappresentare San Paolo sotto le vesti di quei personaggi storici che i manuali caratterizzano con una parola, fissando per loro, come un passaporto, un programma di idee in cui tutto è semplice, chiaro e ben ordinato. Racine è il dolce Racine. Robespierre è una tigre sanguinaria.
Solo l'uomo per cui la vita non è altro che un insieme di formule astratte non può contraddirsi nei suoi libri.
Il flusso di impulsi discordanti è, in realtà, la caratteristica di anime possenti, e a maggior ragione dei grandi mistici; trovarli nei loro scritti, lungi dal vedervi una difficoltà, li considero, tutt'al contrario dei nostri critici, una prova di autenticità... Non solo lo dico senza paradosso, ma si vedrà che là è l'essenza del mio pensiero; le epistole di San Paolo in cui regnerebbe la perfetta unità che reclamano i nostri intellettuali, non sarebbero di San Paolo.
«Il genio di San Paolo», ha detto uno dei suoi commentatori, [12] «così complesso e vario, fatto di contrasti, di opposizioni violente, di antitesi assolute e irriducibili...».
E quella opinione riassume quella della maggior parte dei critici che, senza essere accecati dal razionalismo, lo hanno esaminato.
Il problema, scartati tutti gli aneddoti divertenti, è questo: Vi sono nelle epistole delle tendenze opposte e persino contraddittorie. Possono aver coesistito in San Paolo, oppure è necessario supporre scrittori diversi?
Esse possono coesistere, perché l'uomo è eminentemente homo duplex e perché le personalità superiori più di ogni altra sono complesse; ma esse coesistono soprattutto nei mistici. In realtà, la critica interna estremista non solo ignora la psicologia più generale, ma ignora del tutto la mentalità mistica.
La mentalità mistica differisce dalla mentalità profana proprio perché ammette l'azione di elementi che sfuggono all'esperienza. Tutte le contraddizioni, per il mistico, si risolvono in Dio.
Mostrerò, nel volume che seguirà questo, su quali conflitti di nozioni contraddittorie si è costruita la leggenda del Dio Gesù.
Parlando dei libri dell'abate Turmel, il signor René Gillouin ha scritto [13] le eccellenti righe che mi serviranno da riassunto:
«La pretesa di procedere in tale materia con un'analisi puramente interna è propriamente insostenibile, e non c'è grande opera dello spirito umano, le Meditazioni di Cartesio, l'Etica di Spinoza, la Critica della ragion pura di Kant, che non fosse facile, con quel metodo, dissociare e ripartire tra numerosi autori. Il processo per eccellenza della creazione intellettuale è la sintesi, che consiste nel riunire e nel fondere, nel fuoco del sentimento o dell'intuizione, idee che non sembravano fatte per andare insieme. L'arbitrarietà apparente della facoltà di sintesi si accresce ancora, in un San Paolo, mistico oltre che intellettuale, orientale e di formazione rabbinica per giunta, di tutte le scorciatoie dell'ellissi e di tutte le oscurità del simbolismo. Pertanto l'analisi non ha problemi a risolvere lo stretto tessuto della sua dialettica in una massa incoerente di contraddizioni. Ma questo perché l'essenziale, il principio di vita che lo rendeva unificato è scomparso, si è evaporato senza lasciare traccia.
Spetterà egualmente al nostro prossimo volume spiegare quali furono, in San Paolo, le principali di queste tendenze contraddittorie, che hanno avuto per conseguenza le contraddizioni che rileviamo nelle epistole. Per edificare quelli dei nostri lettori che non sono al corrente con queste questioni, diciamo sin d'ora, in due parole, che esse si riassumono in questo: un uomo nato ebreo, profondamente attaccato alle tradizioni della sua razza, che è venuto alla religione misterica che era il tutto primitivo cristianesimo (almeno nella Diaspora), e che, diventato cristiano ed essendo uscito dal giudaismo, non ha mai cessato di essere, nel profondo del suo essere, un ebreo. E lui stesso lo ha scritto un giorno in uno dei poemi tanto barbari quanto geniali che sono quasi tutte le pagine delle epistole:
Io mi sono fatto Giudeo con i Giudei, al fine di guadagnare i Giudei,
Come sotto la Legge, a coloro sotto la Legge, per guadagnare coloro sotto la Legge,
Come senza la Legge, a coloro senza la Legge,
Pur non essendo senza la legge di Dio, ma nella legge di Cristo,
Al fine di guadagnare coloro senza Legge.
Mi sono fatto debole con i deboli, al fine di guadagnare i deboli,
Mi sono fatto tutto a tutti. [14]
Soltanto, ciò che San Paolo considerava uno sforzo della sua volontà era, in realtà, il grido molteplice del suo cuore.
L'errore di principio dei critici estremisti è di attribuire agli autori che studiano la loro propria mentalità; sotto il pretesto che la ragione è la ragione, e che la ragione è la loro ragione, questi critici non possono trattenersi dall'immaginare alla stregua del loro cervello il cervello di un San Paolo; nel voler ricostruire i motivi che lo hanno fatto agire e i ragionamenti che ha potuto tenere, gli prestano il loro proprio modo di pensare e di ragionare.
Bisognerebbe ricordarsi però che San Paolo non è uscito dalla scuola di Aristotele. A chi vuol rendersi conto del suo modo di pensare e di ragionare basterà leggere, per esempio, nell'epistola ai Galati, i capitoli 3-5:12. Vi si troverà un'argomentazione di cui il meno che si possa dire è che confonde le nostre abitudini mentali; si basa su testi svuotati del loro significato; trae deduzioni che non ci appaiono in alcun modo incluse nelle premesse e procede il più spesso per analogie. Questi procedimenti, egli non le ha inventate. Sono, più o meno, quelli in uso nelle scuole rabbiniche dell'epoca: abbastanza passi del Talmud sono stati tradotti per poterlo verificare; e non c'è affatto bisogno di ammettere che sia stato allevato «ai piedi del rabbino Gamaliele»; è sufficiente che sia stato allevato all'ombra della sinagoga.
Non accusiamo i rabbini, che hanno peraltro compiuto una delle opere più elevate della storia umana; la loro mentalità non è loro peculiare; non solo fu quella di Filone, eppure così nutrito di ellenismo, ma persistette in un gran numero di Padri della Chiesa la cui ascendenza non era affatto giudaica. Ma comprendiamo, per contro, quanto è lontana dalla logica come la intendiamo noi.
Per ciò che concerne specialmente San Paolo, sembra che, per la natura stessa della sua mente, abbia spinto all'estremo i difetti della sua educazione. Ascoltiamo il signor Alfred Loisy parlare [15] delle «deviazioni della sua logica», delle «sue argomentazioni sottili, vere e proprie scappatoie, giochi di parole con cui si abbaglia lui stesso e che non sono altro, se le prendiamo per buone, che ripetizioni convolute, contorte, rabbiniche, di un postulato che non discute».
«Argomentazione da visionario», scrive altrove, [16] «che ritrova in tutti i testi biblici l'idea che porta in sé... Ragionamenti abracadabrici...».
Ecco l'uomo di cui i nostri critici osano dire: «Logicamente, San Paolo non avrebbe potuto professare che...».
Non c'è nulla lì che sminuisca San Paolo. Si può essere un grande uomo senza essere un logico. Le qualità della sua mente sono di un ordine diverso dall'ordine della logica. E, dopo tutto, se le idee che ha espresso contano per noi, perché hanno rinnovato il mondo, il tipo di dimostrazione che ne ha dato conta meno. I motivi per i quali gli uomini si immaginano di agire non hanno spesso alcun rapporto reale con le loro azioni; le forze che li spingono sfuggono alla loro intelligenza; lo spirito che li anima è un dio che non dà le sue ragioni, ed è sufficiente che soffi.
Ma si deve andare più lontano. Nessuna comprensione di San Paolo è possibile se non si è penetrati fino alle origini stesse del suo misticismo. Il signor Lévy-Bruhl ha dimostrato, in un modo che sembra definitivo, che il famoso principio di contraddizione (sul quale, abbiamo visto, è basata la critica estremista) non si è sempre imposto sul funzionamento dell'intelligenza umana. Appellandomi ai suoi lavori, e ponendo come principio [17] la distinzione tra il pensiero razionale e il pensiero irrazionale e il carattere essenzialmente irrazionale del pensiero mistico, ho mostrato che il pensiero irrazionale domina tra le popolazioni primitive e diminuisce con lo sviluppo delle civiltà, ma che ogni rinascita religiosa implica (ovviamente sotto le forme adeguate al tempo e all'ambiente) un ritorno di mentalità irrazionale e primitiva.
Infine, lungi dal restare l'appannaggio dei primitivi e dei selvaggi o quello degli incolti, né la caratteristica delle rinascite religiose, la mentalità irrazionale (si veda l'intuizione in Bergson) è la fonte che ravviva le grandi intelligenze fornendo loro elementi di pensiero che nessuna razionalità potrebbe elaborare. [18]
Al signor Whittaker, che mi obiettava un giorno che San Paolo non era un primitivo, risponderò dunque che la mentalità irrazionale, mistica e in un certo senso pre-logica non è il fatto dei soli primitivi, e citerò, d'altra parte, queste righe del maestro:
«La mentalità di San Paolo è, sotto certi aspetti, quella dei primitivi... egli prende per realtà le immagini del suo cervello... egli non distingue la parte dal tutto, il particolare dal generale, l'individuo dalla specie... ecc., ecc...». [19]
Ho domandato poc'anzi se si potesse concepire nello stesso tempo San Paolo come un uomo cresciuto nei metodi della logica rabbinica, e come un logico nel senso moderno. Mi domando ora se sia decentemente permesso scrivere dell'uomo di cui il signor Loisy ci fa un tale ritratto: «Logicamente, San Paolo non avrebbe potuto professare che...».
E se ci fosse bisogno di più ampie spiegazioni, rimando agli studi psicologici e persino patologici che sono stati scritti per un quarto di secolo su certi casi debitamente analizzati di misticismo. [20]
Riassumiamo.
La critica interna pretende di dissociare in un testo gli elementi che vi sono contenuti e ricercare come questi elementi debbano essere attribuiti a questo o quel periodo, a questo o quell'ambiente, a questo o quello scrittore.
Per dissociare questi elementi, può ricorrere all'analisi filologica.
Oltre all'analisi filologica, opera per ragionamento, vale a dire esamina se, dal punto di vista che il critico ritiene essere quello della ragione e della logica, tale elemento del testo è conciliabile con tal altro, e ricerca, dallo stesso punto di vista, ciò che gli scrittori hanno potuto o non hanno potuto scrivere.
Su cosa si basa la legittimità di questi procedimenti?
Nel primo caso, su qualcosa di abbastanza oggettivo: il lessico, la sintassi, lo stile degli scrittori.
Nel secondo caso, sul postulato che il ragionamento del critico sia valido tanto per gli scrittori che studia quanto per sé stesso, — cioè che la ragione e la logica del critico corrispondano ad una ragione e ad una logica eterna ed universale, e che gli scrittori studiati da lui non hanno potuto ragionare diversamente da quanto lo faccia lui stesso.
Non appena procede indipendentemente da altri mezzi di indagine, e in particolare dall'analisi filologica, la critica interna non ha dunque, in definitiva (e questa sarà la nostra conclusione), altro fondamento che il seguente duplice principio, di cui il primo rientra nel razionalismo inteso nel senso normale della parola:
La ragione è sempre e dappertutto la stessa, e di cui il secondo è tributario dello stesso razionalismo inteso questa volta in senso peggiorativo:
Quella ragione eterna e universale non è altro che quella del critico stesso.
Alla critica interna così concepita, io oppongo un non possumus assoluto.
Quando i critici estremisti intendono stabilire che tali e tali dottrine, tali e tali regole di condotta formulate nelle epistole, si contraddicono, io rispondo dunque semplicemente, e anche supponendo che la contraddizione sia reale:
— In effetti, San Paolo è stato diviso tra due tendenze contrarie, tra due dottrine contrarie, se volete.
E se si tratta di provare che San Paolo ha dovuto pensare questo, ha dovuto scrivere quello, io non posso che constatare:
— In effetti, avrebbe dovuto farlo; ma non l'ha fatto.
E mi attengo a quella risposta.
L'esegesi conservatrice si sforzava un tempo di «armonizzare» i testi contraddittori. Questo è un errore in cui non avremo paura di cadere.
Tutte le contraddizioni che voi scoprirete, miei cari colleghi (e sempre supponendo che esse siano reali), non possono che farmi capire meglio il fuoco ribollente di contraddizioni che era l'anima di San Paolo; tutti i suoi attacchi alla vostra logica, non possono che farmi ammirare di più la geniale assenza di essa nel suo cervello.
E tale sarà l'utilità di una critica interna meglio compresa. Dissociare nei testi gli elementi contraddittori e gli «illogismi» che vi sono contenuti, al fine di dissociare gli elementi contraddittori contenuti nel pensiero dello scrittore e di riconoscere le particolarità della sua psicologia.
NOTE
[1] Temps, 13 settembre 1928.
[2] Delafosse: Ecrits de Saint Paul, 2, pagina 27.
[3] Ibidem, 3, pagina 67.
[4] Ibidem, 2, pagine 38 e seguenti; anche pagine 3 e seguenti.
[5] Delafosse: Ecrits de Saint Paul, 1, pagine 59 e seguenti.
[6] Ibidem, 3, pagine 101 e seguenti.
[7] Goguel, Introduction au Nouveau Testament, volume 4, 1, pagine 58 e seguenti.
[8] Aspects de la biographie, 1928, pagine 48 e seguenti.
[9] Nouvelles Littéraires, 17 gennaio 1925.
[10] La Pensée de J. J. Rousseau, 1929, pagine 83 e seguenti; si veda già, pagine 48 e seguenti, l'esposizione degli stessi principi.
[11] Les Marges, 1929, 7, pagina 157.
[12] Toussaint, l'Hellénisme et l'apôtre Paul, pagina 177.
[13] Nouvelles Littéraires, 5 giugno 1926.
[14] 1 Corinzi 9:20-22.
[15] Mystères païens, pagina 252, 2° edizione, pagina 244.
[16] Livres du Nouveau Testament, pagina 30.
[17] Dieu Jésus, pagine 100 e seguenti e, un po' meno brevemente, in Demain, ici, ainsi, la Révolution.
[18] Io preciserò il mio punto di vista nelle quattro proposizioni seguenti:
1° accanto al pensiero razionale, o piuttosto prima del pensiero razionale, esiste nell'uomo un pensiero irrazionale, come il signor Lévy-Bruhl ha dimostrato;
2° quel pensiero irrazionale è alla base del pensiero mistico; vi si perpetua eminentemente, di modo che il pensiero dei mistici, per quanto colti possano essere, presenta caratteri del pensiero irrazionale primitivo;
3° ogni ritorno religioso è un ritorno a quel pensiero mistico irrazionale;
4° i grandi rinnovamenti del pensiero razionale stesso avvengono il più delle volte solo sotto la sua influenza.
[19] Alfred Loisy: Epître aux Galates, pagina 161.
[20] In particolare, Ferdinand Mirel: Essai sur l'introversion mystique, 1918.
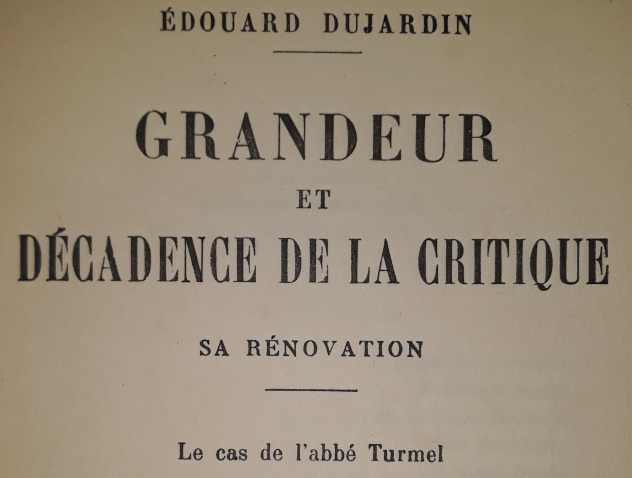
Nessun commento:
Posta un commento