(segue da qui)
I
GLI AVATAR DELLA CRITICA
Non c'è bisogno di ricordare che se esiste una storia delle origini del giudaismo e del cristianesimo, è alla critica dei testi biblici che essa è dovuta. Quali erano i libri della Bibbia prima della critica? Degli scritti sacri, vale a dire libri in cui gli uomini cercavano e trovavano i simboli della loro fede. Con la critica, questi libri sono diventati i documenti in cui si è potuto apprendere come quella fede si era formata e come era evoluta, vale a dire la storia stessa dell'anima umana.
Applicata dapprima alle scritture sacre del giudaismo, il successo, anche se meno categorico di quanto si credette all'inizio, non fu meno considerevole. Erano bastate due generazioni di studiosi per reperire, nei libri mosaici, opere di epoca e di spirito diversi che erano state successivamente riunite; se un grandissimo numero di problemi restano da rivisitare, alcuni principi fondamentali sono stati posti, e alcuni grandi fatti sembrano fuor di discussione.
Che un lavoro analogo potesse essere intrapreso per le scritture sacre del cristianesimo, l'idea non aveva potuto mancare di venire agli studiosi. Già si avevano riconosciuto tra i diversi libri del Nuovo Testamento — vangeli sinottici, vangelo secondo Giovanni, Apocalisse, Epistole — correnti diverse attestanti momenti diversi nella costituzione del cristianesimo; non si potevano discernere nell'interno stesso di ciascuna di loro delle particolarità che avrebbero permesso di concludere per amalgami analoghi a quelli che presentavano i libri del giudaismo? Non c'era forse motivo di esaminare se ciascuno di questi libri non fosse esso stesso, come i libri mosaici, la compilazione, se non la combinazione, di opere dovute a scrittori che si sarebbero succeduti durante i primi due secoli, vale a dire fino all'epoca in cui la raccolta divenne canonica e di conseguenza intoccabile?
Se tuttavia la cosa poté sembrare possibile a priori per i vangeli e l'Apocalisse, ci si domandò a lungo, e molti critici si domandano ancora, se si fosse autorizzati ad assimilare a queste raccolte quella delle epistole paoline, e se non si dovesse al contrario considerare quella come il solo libro della Bibbia che fosse (salvo ritocchi e interpolazioni) l'opera dell'uomo al quale furono attribuite. Ma era proprio il compito della critica risolvere il problema.
I mezzi di indagine sembravano non poter essere altri che quelli che erano stati impiegati per lo studio dei testi giudaici:
Dapprima, l'esame delle testimonianze suscettibili di portare qualche luce sui fatti riportati nei testi.
In seguito, la ricerca in questi testi stessi di tutte gli indizi o allusioni che permettono di situarli nella storia.
Infine, la critica interna. Nella sua accezione più ampia, quella espressione si applica, come abbiamo detto più sopra, all'analisi dei testi presi in sé, indipendentemente dai dati forniti altrove, e ha per scopo di dissociare gli elementi che vi sono contenuti e di ricercare di scoprire come questi elementi possono essere attribuiti a questo o quel periodo, questo o quel milieu, questo o quello scrittore.
Tra i mezzi che impiega la critica interna si colloca in primo luogo l'esame filologico dei testi; se diversi scritti di autori e di epoche diverse si trovano sovrapposti o combinati in un libro, deve essere possibile discernere particolarità di lessico, di sintassi, di stile, che daranno qualche volta dei risultati dubbi, ma qualche volta dei risultati certi.
Accanto a questo procedimento, il cui valore scientifico è indiscutibile ma che esige un sapere considerevole, ne esiste un altro, un po' alla portata di tutti gli studiosi, che si basa sul semplice ragionamento e che, senza far intervenire i dati filologici, studia nei testi le idee, le dottrine, le situazioni in quanto idee, in quanto dottrine, in quanto situazioni. È a questo procedimento che si limita più comunemente il nome di critica interna, riservando al primo quello di critica filologica. [1] Lo scopo della critica interna sarà dunque di reperire in uno scritto le cose che non possono provenire dallo scrittore e dall'epoca alla quale le attribuisce la tradizione, e di scoprirne la data e il vero autore.
Due esempi, per le persone mal introdotte in queste questioni: nei cosiddetti libri di Mosè, si dissoceranno i testi provenienti da un'epoca in cui l'unità del culto non è stabilita in Israele, e quelli in cui il tempio di Gerusalemme è il solo luogo in cui esso si pratica legalmente.
Nei vangeli, si dissoceranno i testi dove Gesù non si dà come Messia e quelli, di uno spirito tutto diverso, dove lo scrittore vuole che egli si sia attribuito quella qualità: due concezioni diverse di Gesù, due epoche, due scrittori.
Il pericolo della critica interna, lo si vede già, è la parte considerevole che dà all'apprezzamento soggettivo dello studioso, il quale sarà fatalmente tentato di esagerare le differenze e trarne delle conclusioni abusive. Ma i pericoli di un metodo non si manifestano generalmente allorché questo è ai suoi inizi e ci si tiene sempre un po' in guardia, ma quando il successo è venuto e si tratta di scoprire cose che i predecessori non avevano visto, vale a dire allorché gli studiosi, come gli uomini politici, si abbandonano al demone della rivalità...
Tali eccessi si erano già verificati nello studio dell'Antico Testamento; non potevano mancare di verificarsi in quello del Nuovo. La crisi fu precipitata dall'avvento dei metodi che, all'inizio di questo secolo, rinnovarono gli studi di storia delle religioni.
Il punto di partenza di questi nuovi metodi fu nei lavori dell'antropologia inglese, di cui non si saprà mai abbastanza riconoscere il valore, e che portarono nel 1889 a quel capolavoro di penetrazione scientifica che è la Religione dei Semiti di Robertson Smith. Per molto tempo, però, gli esegeti professionisti, autori di «introduzioni» all'Antico e al Nuovo Testamento sembravano considerare l'antropologia inglese come qualcosa indegno di loro, e si vide la banda di queste dotte persone continuare a dissertare su R¹, R² e R³, senza interessarsi a nulla che fosse al di fuori del piccolo gioco delle loro combinazioni.
La gloria di aver introdotto in Francia i lavori e i metodi dell'antropologia appartiene al signor Salomon Reinach, [2] in cui questo illustre studioso si dimostrò lui stesso uno degli iniziatori della scienza contemporanea.
Allo stesso tempo come l'etnografia, il folklore apriva lo studio delle religioni a intuizioni interamente nuove. Ispirandosi a tutte queste scoperte, ma sistematizzandole in una dottrina che è una delle opere più considerevoli della mente umana, Emile Durkheim infine fondò alla fine del secolo scorso la scuola sociologica e cercò la soluzione dei problemi della storia delle religioni nello studio comparato dei fenomeni religiosi attraverso l'evoluzione della società stessa. [3]
In un ordine di ricerche parallelo, il signor Lévy-Bruhl pubblicò nel 1910 il primo di tre opere magistrali la cui importanza si irradia su diverse discipline e che noi consideriamo cruciali per la comprensione delle origini cristiane. [4]
Applicando gli stessi principi in un altra branca dell'erudizione, gli studiosi tedeschi Reizenstein [5] e Bousset [6] spalancarono allo studio del cristianesimo primitivo le porte del mondo ellenistico, in attesa che il primo di questi due studiosi gli aprisse quelle del mondo iranico.
Il signor Alfred Loisy, infine, dopo aver avuto la gloria di liberarlo dall'esegesi confessionale della vecchia scuola tedesca, [7] ebbe qualche anno più tardi quella di farsi propagatore dei metodi moderni. [8]
Nessuno esigerà dagli studiosi che studiano la storia del cristianesimo che siano iniziati alle scienze derivate dalla psicologia e dalla patologia, e ancor meno che si impegnino in pratiche psicoanalitiche; ma nessuno negherà che queste scienze e quella pratica abbiano fornito informazioni di altissimo valore per chiunque studi il fenomeno religioso e in particolare la mentalità dei primi gruppi cristiani. E ne è lo stesso per le ricerche che sembrerebbero di ordine puramente letterario sulla natura della poesia e la nascita del poema, e in maniera generale sulle leggi del linguaggio. È innegabile che i lavori del P. Jousse, anche se non lo si segue in tutte le conclusioni che vorrebbe trarne, hanno portato dati preziosi alla comprensione dei libri biblici.
Vogliamo semplicemente attirare qui l'attenzione sull'immensa apertura d'orizzonte che, dopo una lunga preparazione, si è fatta da un quarto di secolo. È insieme il tempo e lo spazio che fanno la loro entrata. Le pareti della cella o, se si vuole, della biblioteca, stanno crollando, e l'aria aperta penetra da tutte le parti. D'ora in poi, sarà nella storia degli uomini che lo studioso cercherà una risposta ai problemi umani. Non che l'analisi dei testi in sé non mantenesse la sua ragion d'essere e in molte occasioni restasse necessaria; ma diveniva evidente che non poteva più bastare a sé stessa e, per dirla tutta, che doveva accontentarsi di un ruolo ausiliario.
Alcuni studiosi che avevano pure fatto la loro carriera sui vecchi sentieri non esitarono ad entrare nei nuovi, e vi trovarono nel contempo il rinnovamento della loro erudizione e il ringiovanimento della loro reputazione. Altri, al contrario, si rifiutarono di sapere qualcosa.
Mancanza di apertura mentale; educazione primaria; abitudini acquisite, di cui non ci si è potuti sbarazzare; mancanza di cultura generale; orizzonte ristretto ad un piccolo numero di domande sempre le stesse; vecchie polemiche perseguite per anni; una sorta di idea fissa che impedisce di vedere tutto ciò che accade al di fuori; e poi, quella certezza di sé che viene a poco a poco a coloro che si chiudono nel proprio pensiero; e, come conseguenza, l'indifferenza alle novità e una volontà tenace di ignorare tutto ciò che esula dal ritmo del proprio lavoro quotidiano; Infine, per coronare il tutto, quella mentalità razionalista, sulla quale dovremmo spiegarci, e che sin d'ora possiamo definire la fede non nella ragione, ma nella propria ragione; la Chiesa la chiama il peccato di orgoglio, noi la chiameremo più severamente tra un momento.
Se alle orecchie dello studioso così svantaggiato arrivassero, per la casualità di qualche articolo di rivista, di qualche pagina di un libro consultato altrove, un'eco dei lavori dell'antropologia e dell'etnografia sui semi-civilizzati, dei metodi sociologici stabiliti da Durkheim, delle scoperte di un Lévy-Bruhl, ci sarà un'alzata di spalle; le indagini di un Reitzenstein e della sua scuola, benché toccano più da vicino i suoi studi, gli saranno sospette, e mi domando se del signor Loisy leggerà fino alla fine i Mystères Païens e il Sacrifice! Mentre gli stessi domenicani della Revue Biblique, i gesuiti degli Etudes, senza accettare le conclusioni che gli studiosi indipendenti traggono, prendono in considerazione i metodi comparativi e tutt'al più li discutono, lui non vuole averci niente a che fare.
Ma egli non si limiterà a questo disprezzo. Verso le novità che vengono a contraddire l'opera della sua vita, uno studioso non può avere che due attitudini: uno sforzo leale, oppure una feroce e definitiva ostilità. Abbiamo detto più sopra che la crisi della critica interna fu precipitata dall'avvento di nuovi metodi. Di fronte a questi metodi che, lasciando alla critica interna solo il posto modesto al quale essa ha diritto, la cacciano dal trono che aveva usurpato, come reagirebbe lo studioso che gli restasse fedele? Per una sorta di protesta, per una volontà di affermare la sua opposizione, direi quasi per una sfida inconscia, chiudendosi più strettamente che mai nel suo procedimento, andrebbe a spingerlo fino ai suoi ultimi oltraggi. I nuovi mezzi di indagine che gli offrono la storia delle civiltà, il metodo comparativo, la sociologia e le sue appendici, l'uomo della critica interna non solo gli ignora, ma intende provare che sa farne a meno. Me solo, e questo basta... Così parla il critico interno... Also sprach Zarathustra...
Abbiamo sottolineato poco fa che il primo pericolo della critica interna consisteva nella parte considerevole che dava all'apprezzamento soggettivo dello studioso. Eccolo, infatti, dinanzi ai suoi testi; li analizza; li scruta; li soppesa; si sforza di dissociarne gli elementi. Qual è la regola che lo guiderà in questo lavoro? Ha rifiutato il concorso della critica esterna così come dei nuovi metodi, così come (è il caso dell'abate Turmel) della filologia stessa. A sua disposizione non resta che il ragionamento, l'antico sillogismo più o meno vestito alla moderna.
Lo studioso che attinge alla storia, all'antropologia e al metodo comparativo, si basa sui fatti; lo studioso che si concentra sulla critica interna si basa sul valore del suo ragionamento. Se ne vedranno presto numerosi e caratteristici esempi. Ed è la questione del razionalismo che si pone. Ai fatti che possono fornire tanto la critica esterna quanto i metodi nuovi e la filologia stessa, il critico interno estremista oppone, in ultima analisi, le leggi della ragione.
Le leggi della ragione? Abbiamo già corretto: le leggi della sua ragione.
Ho spiegato altrove [9] i diversi significati che convengono al termine di razionalismo, e come importi non confondere l'accezione nobile che gli si possa dare con l'accezione peggiorativa che noi le attribuiamo più spesso. E la questione è così importante che io domando il permesso di ricordare come ho definito queste accezioni.
In linea di principio, si definisce razionalista l'uomo che, ignorando la natura tutta sperimentale della ragione, vi vede la facoltà di concepire verità eterne e ne fa di conseguenza la regola unica e infallibile di tutta la conoscenza. Questo razionalismo è quello, per esempio, di Platone e di Cartesio; e, se è lecito combatterlo, conviene onorarlo.
Ora, è proprio quella concezione della Ragione eterna e universale che i nuovi metodi contraddicono, mostrando tutte le variazioni che ha subito la ragione umana nel tempo e nello spazio, dai semi-civilizzati fino a noi, dalle scuole rabbiniche fino alle scuole ellenistiche, dai grandi mistici fino ai positivisti.
Di tutto ciò, lo studioso rinchiuso nella critica interna non vuole saperne nulla; egli pone in linea di principio che le deduzioni che sono giuste per lui sono state giuste per tutti gli uomini, quindi per San Paolo; la ragione è la ragione; il ragionamento che lui tiene, San Paolo non ha potuto non tenerlo; ciò che è evidente per lui non ha potuto non essere evidente per San Paolo. Volgarmente parlando, si può dire che la critica interna riposa su questo principio: gli autori del Nuovo Testamento hanno potuto avere idee diverse dalle nostre, ma non hanno potuto ragionare diversamente dall'uomo che li studia. E così il razionalista diventa, nel senso peggiorativo del termine, colui che, non contento di fare della ragione la regola unica e infallibile della conoscenza, eleva la piccola ragione del suo tempo e del suo ambiente al rango di ragione suprema, e, mentre un Platone e un Cartesio si sforzano magnificamente di far emergere il volto di una grande ragione universale, egli si accontenta di erigere in principi assoluti le verità a sua misura.
È questo razionalismo di seconda serie che, per non turbare i veri razionalisti, noi chiameremo il «pseudo-razionalismo».
Si è rimproverato agli studiosi cattolici di subordinare le loro ricerche all'a priori delle verità rivelate. Vedo qualcosa di più pericoloso nel tipo di razionalista che postula a priori l'universalità della propria facoltà di ragionare: più pericoloso, perché il cattolico riconosce apertamente di obbedire ad un magistero, mentre il razionalista immagina e vorrebbe far credere di non obbedire ad alcuno.
Supponiamo che lo studioso che si è votato all'esclusiva critica interna abbia ricevuto dalla natura una mentalità ribelle al sentimento religioso, ostile al misticismo, andiamo fino all'estremo, una mentalità alla Homais... Nietzsche ha descritto il «Filisteo colto»; supponiamo il Filisteo erudito... Si indovina già al presente in quale spirito il punto di vista della Ragione Universale ed Eterna lo condurrà a comprendere le cose religiose, gli uomini che si è dato missione di studiare e i testi sui quali esercita le sue facoltà intellettuali.
Abbiamo seguito, grado per grado, la decadenza della critica interna. Nella prima fase, è lo studioso che chiude la sua porta ai nuovi metodi e si chiude in casa con i suoi testi. Ben presto, è alla critica esterna stessa che egli rinuncia. La filologia sola gli resta per salvarlo dalla sua soggettività; ma troppo spesso essa la contraddice; fuori dalla porta, la filologia! Le quattro mura della critica interna sono chiuse e per sempre.
E vi è più di un egocentrico che, con la sua sola ragione, vale a dire con i suoi pregiudizi eretti a criterio di evidenza, demolisce e costruisce, sul piano di una mentalità da «Filisteo erudito» inaccessibile a qualsiasi comprensione delle cose religiose, senza che nessun angelo abbia mai la possibilità di discendere dal cielo per toccarlo sulla spalla e gridargli contro.
Abbiamo appena presentato ai nostri lettori l'abate Turmel. Si giudicherà se ne abbiamo delineato un ritratto a tinte fosche.
NOTE
[1] Avvertiamo una volta per tutte che, per la rapidità della nostra esposizione, intenderemo in questo modo per «critica interna» quella praticata senza il concorso della filologia.
[2] Il primo volume di Cultes, Mythes et Religions, pubblicato nel 1904, è una raccolta di studi, di cui alcuni erano stati pubblicati nel 1900 e anche prima.
[3] Come coronamento, 1912, Formes élémentaires de la vie religieuse.
[4] 1910, Fonctions mentales dans les sociétés inférieures; 1922, Mentalité primitive; 1927, Ame primitive.
[5] 1910, Die hellenistichen Mysterienreligionen.
[6] 1913, Kyrios Christos.
[7] L'Evangile et l'Eglise, 1902.
[8] Dapprima nella Revue d'Histoire et de Littérature Religieuses, passim, poi, 1913-1919, Mystères Païens, 2° edizione nel 1930, e 1920, Essai historique sur le Sacrifice.
[9] Dieu Jésus, pagina 63.
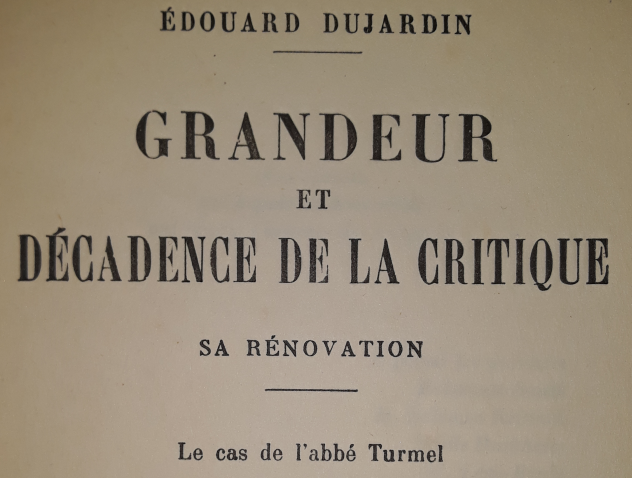
Nessun commento:
Posta un commento